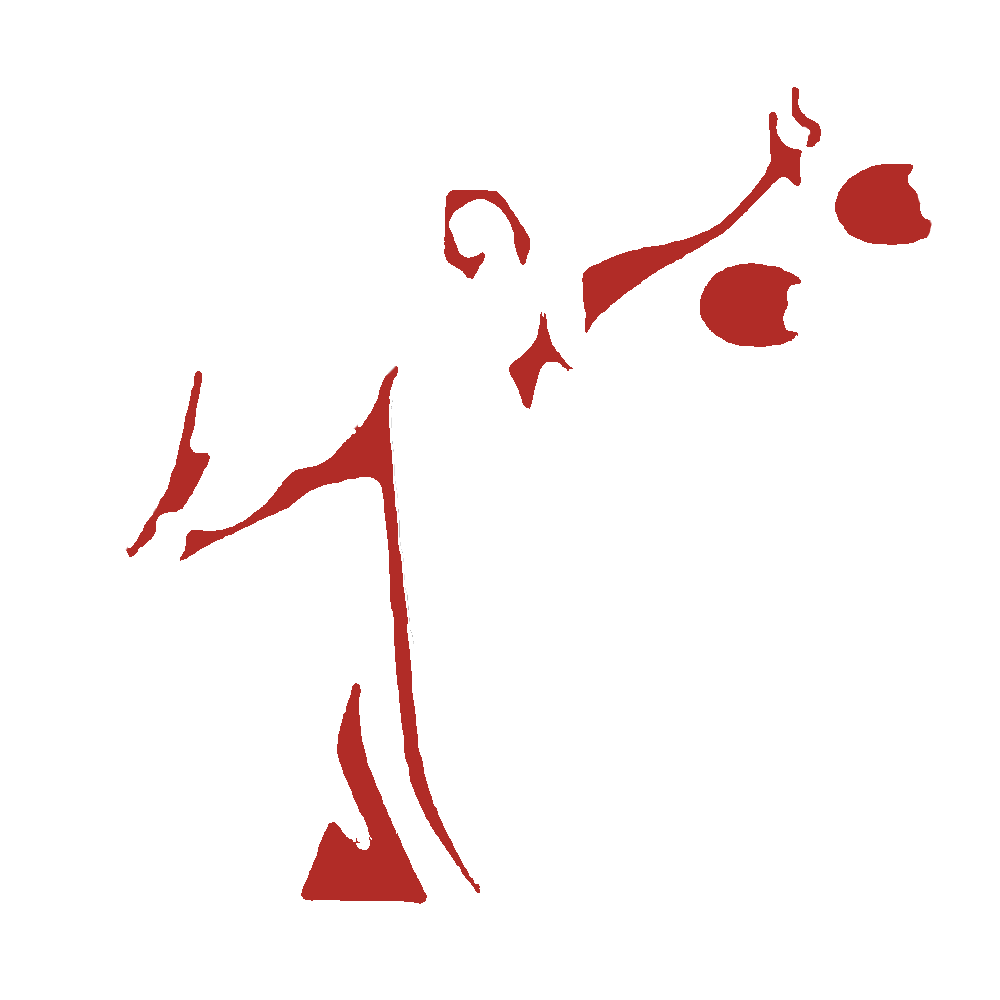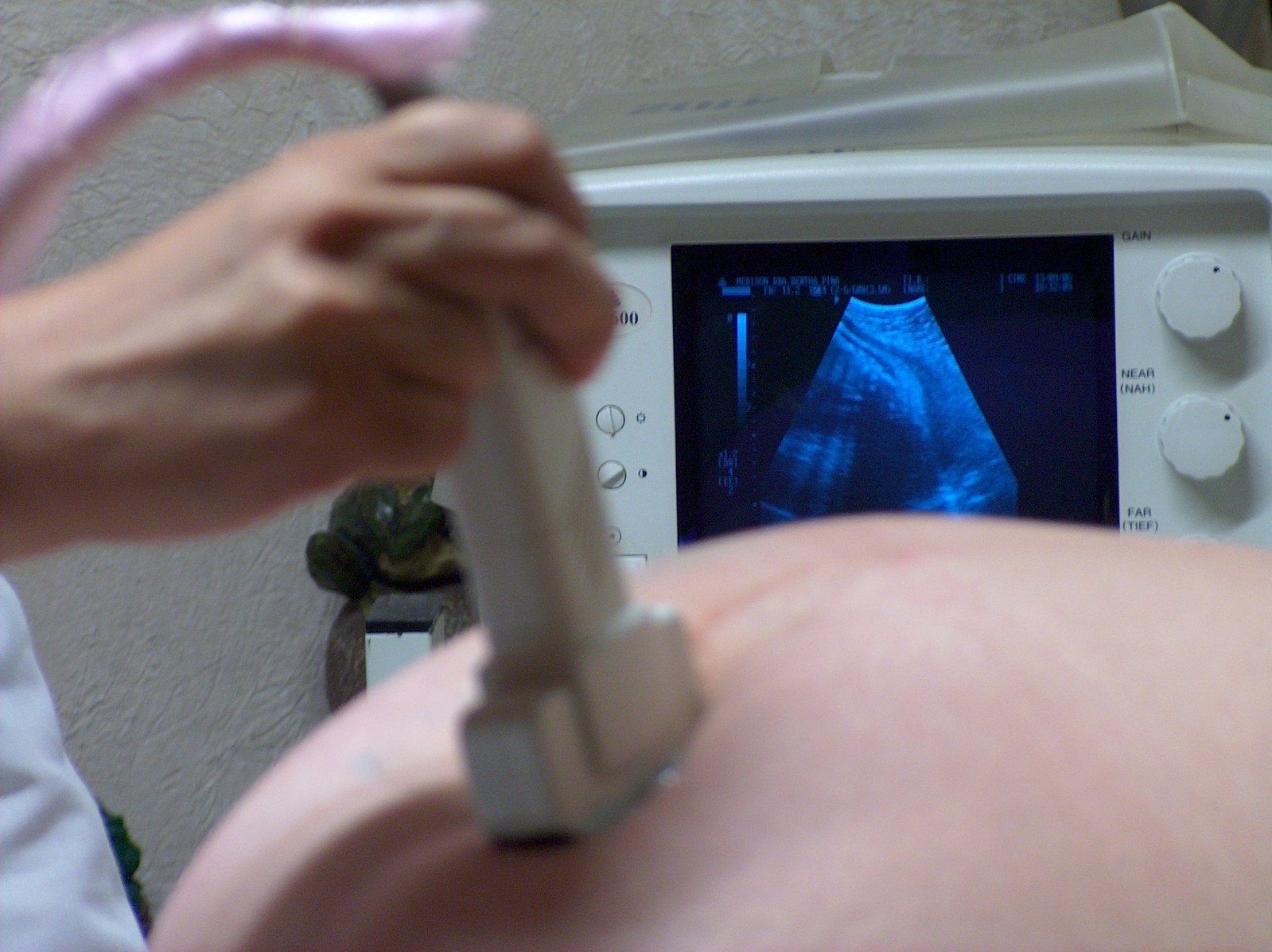Il Decreto Cutro (oggi divenuto Legge) rappresenta una delle novità più significative in materia di diritto dell’immigrazione, in quanto sin dalla sua entrata in vigore nel 2023 ha apportato importanti cambiamenti sul tema dell’accoglienza di migranti e rifugiati.
In un’epoca caratterizzata dal crescere degli spostamenti e dei flussi migratori verso l’Europa, appare necessario comprendere come i Paesi di accoglienza dovranno comportarsi nel valutare le richieste e le istanze dei migranti che, per diverse motivazioni, desiderano insediarsi in nuove realtà ed iniziare una vita diversa, lontana dai propri luoghi di nascita.
Ad essere toccato principalmente dalla normativa in esame è stato il concetto di “protezione speciale”. Infatti la normativa ha modificato tale istituto individuato e regolato dall’art.19, commi 1, 1.1 e 1.2. TU immigrazione d.lgs. 286/98, che già aveva subito delle modifiche con il D.L. n.130/2020 (c.d. decreto Lamorgese).
Con il decreto-legge n. 20/2023 (c.d. “decreto Cutro”), entrato in vigore l’11 marzo 2023, sono stati infatti abrogati il terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell’art.19 del T.U., i quali tra i presupposti per la riconoscibilità della protezione speciale riconoscevano espressamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente.
Tale novità ha aperto significativi dibattiti giurisprudenziali, ma anche politici e sociali: l’interpretazione delle norme, così modificate, non appariva semplice ovvero univoca, soprattutto perché la normativa doveva (e deve) applicarsi a casi variegati, a situazioni di vita diversa che, inevitabilmente, il più delle volte coinvolgono i diritti fondamentali dell’uomo, che rischierebbero di essere violati qualora ci si avventurasse in letture eccessivamente restrittive delle nuove leggi emanate.
In particolare, molti giudici e molte autorevoli Corti, hanno sollevato delle perplessità riguardo al fatto che la nuova disciplina sembra non tenere conto del vissuto dello straniero in Italia.
Nella valutazione della concessione della protezione speciale, la normativa sembra trascurare completamente quanto previsto dall’art 8 CEDU in tema del rispetto della vita privata e familiare di ogni individuo.
Infatti, la nuova legge mira a restringere i motivi per cui lo straniero possa avere diritto a rimanere in Italia in assenza di un clima di persecuzioni e guerre nel Paese di origine oppure di discriminazione. Tuttavia però essa non tiene conto del fatto che, nel pratico, il concetto di “pericolosità” e “disagio” del Paese di provenienza deve essere analizzato in maniera più specifica, non arrestandosi soltanto al riscontro circa la presenza o meno di conflitti armati sul territorio di provenienza, ma anche guardando a concetti quali le possibilità concrete di crescita lavorativa o, per i più giovani, di studio, o anche a discriminazioni più sottili ed “interne” che il singolo potrebbe subire nella propria Terra di origine. Discriminazione che, anche se non riconosciute a livello generale nel paese d’origine, il richiedente invece non subirebbe certamente nel Paese ospite, dove al contrario potrebbe giovare di una vita più serena e dove, il più delle volte, si trova già ad avere intrapreso un proficuo percorso di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
In altre parole, la nuova normativa non tiene conto del nocumento che un soggetto, che lavora e ha una propria vita privata e familiare fatta di reti sociali ed affettive, costruite dopo la fuga dal paese d’origine, potrebbe subire in caso di rimpatrio forzato, che talvolta interviene a distanza di molti anni, quando quasi non si hanno più legami con il paese dal quale si proviene.
Nel tempo, quindi, molti Giudici hanno iniziato a valutare, quando erano chiamati a decidere sulla concessione o meno della protezione speciale ad uno straniero, non solo l’esistenza di situazioni di disagio generalizzato e di pericolosità del Paese di origine, ma anche le condizioni in cui lo straniero vive in Italia, soprattutto se egli non rappresenta, con la propria presenza, un pericolo per la sicurezza nazionale.
Hanno quindi applicato la normativa vigente senza però trascurare le norme di carattere internazionale, come appunto le norme Cedu, che mirano a una tutela più ampia dei diritti umani, intesi anche come diritto a una vita migliore, nonché alla ricerca di una realtà più serena dove stabilirsi e realizzare sé stessi.
Di grande impatto, a tal proposito, è stata la recentissima sentenza del Tribunale di Palermo del 04 dicembre 2024 che ha riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale allo straniero che aveva dimostrato un percorso di integrazione avviato e certificato dalla presenza di un lavoro stabile e dalla presenza di una solida rete familiare e sociale sul territorio italiano.
Il ricorrente, un cittadino tunisino, nello specifico si era opposto al provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, emesso il giorno 20 settembre 2023 con il quale era stata respinta per manifesta infondatezza la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente, lamentata l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato aveva insistito, innanzi al Tribunale, per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione speciale, che gli era stata infine concessa, tenendo conto del significativo percorso di integrazione da lui compiuto.
Lo stesso, come sottolinea il Tribunale di Palermo, non aveva mai subito persecuzioni nel proprio Paese, dal quale era partito ai fini di cercare semplicemente nuove condizioni di vita, nonché possibilità di lavoro diverse e più adeguate per sostenere la propria famiglia. Nel contempo, sempre secondo l’analisi del Tribunale siciliano, sebbene la Tunisia non appariva un Paese pericoloso in senso generico, non essendo un’area interessata al momento da guerre e conflitti, tuttavia, il rimpatrio sarebbe risultato dannoso per il ricorrente che, in Italia, aveva trovato stabilità e serenità a tutti gli effetti.
Il Tribunale, ricorda, infatti, nelle proprie motivazioni, che l’art 19 del d.lgs. 286/98, prevedeva un riferimenti diretto rispetto a cosa configurasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, con conseguente preclusione della facoltà di allontanamento dal territorio italiano. La vecchia formulazione dell’art.19, comma 1.1. del D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito con L.173.2020) dettava dei precisi parametri per consentire tale valutazione, contenendo un espresso riferimento alla “effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”. Ad oggi, nonostante le modifiche introdotte dalla nuova legge, sopravvive, ad avviso dei giudici, la necessità per l’Amministrazione a cui è richiesto il rilascio del titolo di soggiorno, di tenere conto degli obblighi costituzionale e internazionali, ivi compreso il rispetto dei diritti umani fondamentali, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. Si tratta di diritti fondamentali di portata universale richiamati dall’art 8 CEDU, che fa riferimento al rispetto della vita privata e familiare dell’individuo. Tale articolo, infatti, quale norma gerarchicamente superiore e universalmente riconosciuta deve essere rispettato e considerato, pur in presenza delle modifiche normative introdotte dal D.L. 20/2023 (c.d. decreto CUTRO). Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare – pur a seguito dell’abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023). Proprio alla luce di tale richiamo, nonché delle numerose sentenze della Corte Europea sul punto, è stato possibile permettere, anche in presenza delle modifiche dell’art 19, al ricorrente di rimanere in Italia, semplicemente tenendo conto del proficuo percorso integrativo intrapreso nel nostro Paese e “considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l’allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”.
Tale sentenza è sicuramente un importante spunto interpretativo che potrebbe senz’altro divenire un precedente al quale guardare ed eventualmente conformarsi in situazioni simili, tenendo conto che l’art 8 Cedu consente di tutelare in via diretta tutto quel catalogo di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona, e che può essere ragionevolmente invocato in numerose circostanze . Ciò, a riprova di come, in materie così delicate, non è mai possibile tracciare una linea netta e definita ma è sempre necessario applicare il diritto tenendo conto della fattispecie concreta sottoposta al vaglio di natura sociale, ambientale, culturale e se vogliamo anche morale che, debbano avere però, come comune denominatore, la più ampia tutela dell’essere umano sotto tutti gli aspetti e la protezione più vasta dei suoi diritti e necessità, soprattutto quando è in discussione la dignità di un essere umano, ed il suo diritto irrinunciabile ad una vita serena e felice.