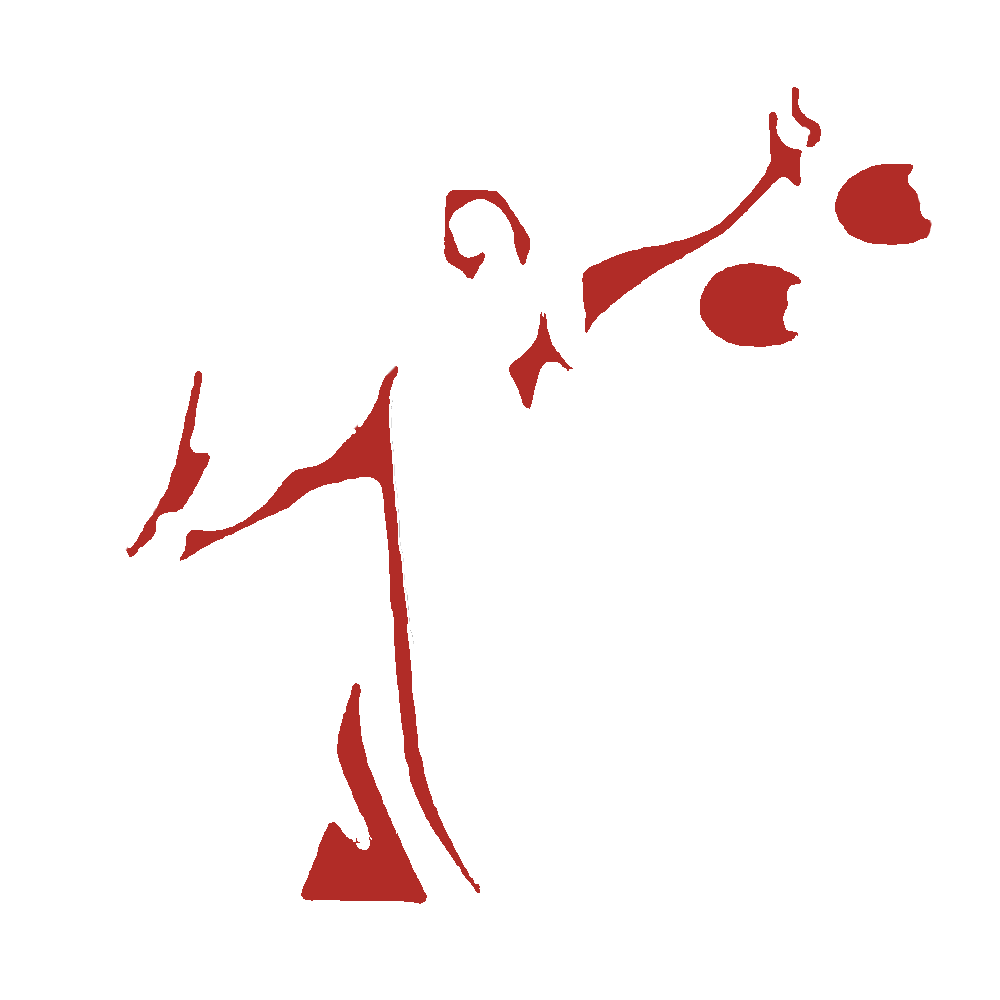Omesso trasferimento del paziente presso una struttura specializzata? È responsabile la struttura sanitaria
È quanto affermato dal Tribunale di Firenze la quale, con sentenza del 21 giugno 2018, ha affermato che: “sussiste la responsabilità della struttura sanitaria per aver omesso di trasferire immediatamente il paziente presso un ospedale specializzato, ovvero dotato delle attrezzature necessarie al trattamento della patologia del medesimo. Tale condotta omissiva configura, infatti, un inadempimento all’obbligo di intervento gravante sull’ente ospedaliero, che impone l’adozione di tutte le misure di emergenza necessarie alla cura del paziente”.
Il caso: Gli eredi di una signora convenivano davanti al Tribunale di Firenze la casa di cura ove la donna era stata ricoverata, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della medesima, da ricondursi a negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici operanti nella struttura convenuta e alle carenze organizzative di quest’ultima.
In particolare, gli attori lamentavano che la donna era stata sottoposta presso la suddetta casa di cura ad intervento chirurgico di protesizzazione dell’anca e che al momento del ricovero si trovava in condizioni già abbastanza precarie.
Secondo quanto rappresentato da parte attrice, durante l’anestesia effettuata prima dell’intervento, alla donna non veniva praticata la trasfusione di sangue pure richiesta il giorno precedente dal personale medico. Nelle ore successive all’operazione chirurgica, dai controlli clinici emergeva il crollo dell’emoglobina nella paziente, la quale veniva conseguentemente sottoposta ad una trasfusione. Soltanto nel primo pomeriggio, all’esito della diagnosi di infarto ed edema polmonare, la donna veniva trasferita presso altra struttura sanitaria, ormai in stato di shock emorragico, e poco dopo decedeva.
Gli eredi evidenziavano che dalla CTU medico legale effettuata in sede di giudizio erano emerse:
| i) una responsabilità omissiva, di natura extracontrattuale, dei singoli sanitari della struttura, i quali avrebbero dovuto decidere per l’immediato trasferimento della donna presso un ospedale dotato di cardiologia emodinamica e di reparto di terapia intensiva già al sorgere dei primi sintomi che avrebbero dovuto far pensare ad un infarto miocardico;
ii) una responsabilità da disorganizzazione, di natura contrattuale, della struttura ospedaliera. |
Gli attori evidenziavano, infine, di aver esperito il tentativo di mediazione, che aveva tuttavia avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta all’apposito incontro e che, nonostante gli esiti della CTU suddetta avessero confermato la responsabilità della struttura nella causazione del decesso della donna, la convenuta non si era resa disponibile ad alcun accordo transattivo.
Si costituiva la struttura ospedaliera, contestando quanto rilevato dagli attori.
Il Giudice, istruita la causa documentalmente, all’esito accoglieva le domande risarcitorie degli attori.
Impatti pratico-operativi
Il Giudice ha anzitutto accertato la sussistenza della condotta negligente della casa di cura convenuta per aver omesso di eseguire sia un controllo preoperatorio al cuore e sia una visita anestesiologica, in quanto tali accertamenti avrebbero consentito di valutare con attenzione il rischio operatorio e l’adeguatezza dell’intervento chirurgico, tenuto anche conto che la paziente presentava già una patologia cardiaca ed aveva un’età avanzata (settantotto anni).
A tal riguardo, il giudicante, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito, infatti, che le omissioni della cartella clinica devono essere interpretate in senso sfavorevole alla struttura ed ha pertanto ritenuto che tali controlli non fossero stati svolti dai sanitari proprio in quanto non presenti in cartella clinica.
Sul punto, il giudice si è peraltro discostato dalle conclusioni del CTU, il quale aveva invece ritenuto che dalla mancata annotazione in cartella clinica della valutazione del rischio operatorio doveva invece farsi discendere che l’intervento era stato valutato dai sanitari come adeguato.
Ciò evidenziato, il giudice ha altresì osservato che il CTU aveva invece correttamente rilevato la grave condotta omissiva tenuta dai sanitari successivamente all’intervento, i quali, pur sospettando l’insorgere di una patologia cardiaca acuta e un evento ischemico non avevano inviato immediatamente la paziente alla struttura ospedaliera specializzata, per consentire un tempestivo trattamento della patologia cardiaca.
Al riguardo, il giudicante, richiamandosi alle conclusioni espresse dal consulente tecnico, ha evidenziato che in tali casi, se il paziente non viene sottoposto a terapia nelle prime due ore dalla comparsa dei sintomi muore nel 70% dei casi e nella specie, la donna era stata trattata con un ritardo di almeno tre ore.
Nello specifico, il giudice ha, infatti, osservato che pur sospettando dell’infarto in atto a partire dalla mattina del giorno successivo all’intervento, i sanitari avevano omesso di trasferire immediatamente la paziente all’ospedale dotato di tutte le attrezzature necessarie al trattamento della patologia, prima che si aggravasse. Soltanto, infatti, nel primo pomeriggio i medici avevano deciso di disporre il trasferimento in questione, ma una volta giunta al pronto soccorso dell’ospedale la donna era già in condizioni praticamente irreversibili.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per violazione dei principi di diligenza, prudenza e perizia nell’adempimento dell’obbligo di intervento sulla medesima gravante, che richiede l’adozione di tutte le misure di emergenza necessarie, quali appunto l’immediato trasferimento del paziente presso strutture specializzate o la convocazione di specialisti.
Il giudice ha dunque accertato la sussistenza del nesso causale tra l’evento morte e la condotta negligente della struttura, peraltro precisando che sebbene il CTU si fosse richiamato alle chance (60-70%) che la paziente avrebbe avuto di sopravvivere se trattata tempestivamente in maniera adeguata, ciò non potesse vincolare il giudice stesso ai fini della qualificazione del danno come mera perdita di chance, avendo piuttosto nel caso di specie il CTU accertato il nesso causale diretto – non certo ma comunque altamente probabile – tra il decesso e la condotta omissiva dei medici.
Il Giudice ha pertanto condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subiti dai figli iure proprio, nonché per la quota del coniuge della donna deceduto nelle more del giudizio, applicando i valori minimi di cui alle tabelle milanesi ai fini della relativa liquidazione, in ragione dell’età della donna deceduta e della conseguente entità del rapporto perduto.
Infine, il giudice ha condannato la struttura sanitaria per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 III comma c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma pari all’importo delle spese legali liquidate, in quanto:
| i) gli attori avevano esperito il tentativo di mediazione, al quale tuttavia non avevano partecipato nè la struttura sanitaria, né la compagnia di assicurazione;
ii) nonostante la perizia del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo avesse accertato la responsabilità della struttura convenuta, quest’ultima e la compagnia assicurativa non avevano proceduto a liquidare in favore dei congiunti neppure una somma in acconto. |
Tribunale di Firenze, sentenza del 21 giugno 2018